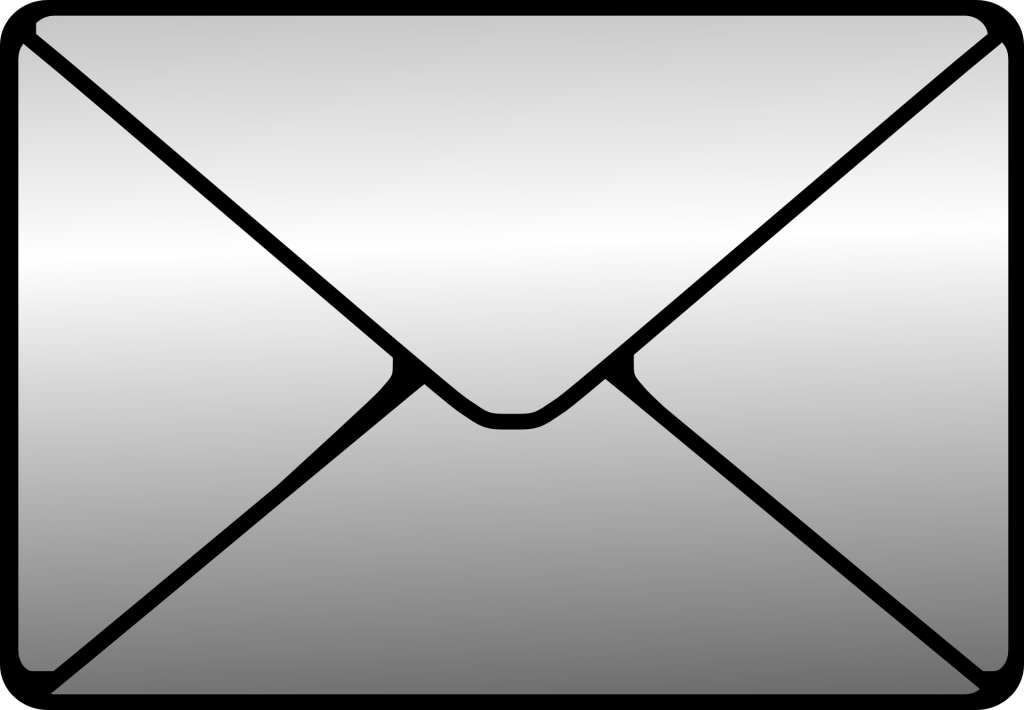Carteggi (27).
Ciao,
che fine ha fatto Ruben? L’hai più visto, l’hai più sentito, ti ha più scritto? E sua moglie? Hai più avuto sue notizie?
Ruben ricordo di averlo incontrato un mattino di settembre, l’anno scorso. C’era vento, faceva caldo. Come al solito era vestito elegante, indossava un abito sartoriale grigio ardesia, camicia bianca, cravatta blu e mocassini scuri. Se ne stava seduto su una panchina davanti al porto. Il maestrale scuoteva le fronde delle palme, trascinava fragranze di frutti. L’aria profumava di essenze esotiche e salsedine.
Ruben mi disse che forse era arrivato il momento di darci un taglio.
“Dare un taglio a cosa?”, gli chiesi.
“Non lo so. Ci devo riflettere”, mi rispose.
Era confuso, scuoteva la testa e continuava a ripetere “Non lo so. Davvero non lo so”. Mi disse che la “recisione di alcune frange” della sua vita gli appariva una soluzione irrinunciabile. “Prudentemente praticabile”: usò queste parole. Mi disse che ci aveva pensato spesso, nell’ultimo periodo. Aveva considerato la questione da ogni punto di vista, tralasciando tuttavia particolari e dettagli che sarebbero potuti apparire pretestuosi, e forse in parte lo erano. Si stava consumando fino a confondersi in un vortice di domande senza risposte. Si interrogava sulla “vacuità degli ideali”.
Non sapevo che cosa dire, mi aveva colto impreparato. Immaginai che Ruben fosse alla ricerca di un piedistallo etico o morale. Una forza motrice che lo spingesse ad accettare una qualsivoglia forma di castrazione dell’anima, tanto bizzarra quanto ineluttabile. Da chi o da che cosa volesse fuggire, però, non mi era affatto chiaro. Ammesso che di fuga si trattasse.
A un certo punto mi mostrò tre buste. “Sono tre lettere. Tutte e tre uguali”, disse con un sorriso a metà.
Si accese una sigaretta.
“Le ho scritte ieri notte”, continuò, “non ricordo più le parole esatte, ma il senso sì, penso di ricordarmelo”.
Gli domandai a chi erano indirizzate. Lui fece no con la testa e restò in silenzio. Fumò badando al tabacco che bruciava lento. Dopodiché buttò la cicca per terra e la spense con la punta della scarpa.
Ci alzammo e ci incamminammo verso il molo.
Percorremmo il lungomare. C’era un andirivieni di coppie e pensionati, un flusso pigro e raccolto. Ci venne incontro una ragazza che spingeva una carrozzina per neonati. Era molto giovane. Indossava jeans e stivali neri. Aveva i capelli scuri, raccolti in una coda alta e lunga. Ci passò a fianco e non potemmo fare a meno di guardare nella carrozzina. Lei rallentò, quasi si fermò, per consentirci di guardare meglio. Il bambino aveva guance tonde e rossastre. Dormiva, avvolto in un lenzuolo celeste di panno morbido. Aveva il braccino adagiato sul cuscino e teneva il pugno chiuso. Ruben lo sfiorò con un dito. Il piccolo ebbe un sussulto, aprì le palpebre, tremolò e agitò un piedino. Ruben ritrasse subito la mano. La ragazza lo guardò e gli fece un cenno, come per dire che non doveva preoccuparsi, che era tutto a posto. Quindi sorrise, sistemò il tettuccio della carrozzina e proseguì per la sua strada.
Rimanemmo per un po’ a osservarla di spalle mentre si allontanava. Poi volgemmo lo sguardo oltre la balaustra della banchina, verso le piccole barche ormeggiate. Lo sciabordio delle onde si mescolava al rumore delle sartie che tintinnavano sugli alberi maestri. Non distante dal parcheggio per le auto, tre gabbiani si spartivano alcuni resti di cibo, un sacchetto della spazzatura.
“Quindi?”, gli chiesi.
“Dimmi una parola magnifica“, disse.
Non gli risposi. Non avevo con me una scorta di parole magnifiche.
“Allora dimmi che cos’è che non funziona?”, domandò.
Aveva gli occhi spenti, rassegnati. Ruben l’avevo sempre considerato un uomo fortunato. Una moglie bellissima, Lea, tre figli amorevoli, una carriera lavorativa esemplare. Da ragazzi eravamo inseparabili. Trascorrevamo giornate lunghe e languide a pescare, fumare, ridere e fantasticare sulle ragazze che ci piacevano. C’erano sempre tramonti rosa e viola, soprattutto in primavera. E quei tramonti abbracciavano noi e il nostro mondo.
Lo guardai. Adesso tutto sembrava inadeguato. Anche noi, eravamo diventati inadeguati.
“Va tutto bene, Ruben. Va tutto bene”, furono le uniche parole che riuscii a dirgli. Ma con le bugie non ci ho mai saputo fare.
Da quel mattino non ho più avuto sue notizie, di Lea, dei loro figli. Alcuni dicono che si siano trasferiti in Toscana, o in Svizzera, ma nessuno sa bene dove. Altri sostengono che siano andati a vivere in Australia. Altri ancora, invece, sono sicuri che Ruben ci abbia dato veramente un taglio, abbia lasciato la famiglia e sia volato in Sud America; che Lea e i figli si trovino in Olanda, dai genitori di lei.
La verità è che nessuno ne sa niente.
La ragazza dai capelli scuri, la ragazza della carrozzina e del neonato, si chiama Lucilla. Ci frequentiamo da alcuni mesi. Ci facciamo compagnia. Ogni tanto ci facciamo abbracciare dai tramonti.
Il bambino si chiama Tommaso. Forse gli farò da padre.
Scrivimi comunque.
A presto.
S. D.